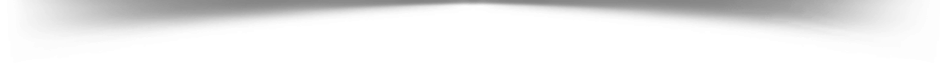Mare d’inferno
- DATE 18 Lug , 2018
- Author: sara
- COMMENTS Leave a comment
Lo sciabordio dolce dell’acqua la cullava, come un ventre materno.
Provò ad aprire gli occhi ma la luce del sole era accecante e si sentiva spossata; perfino sollevare le palpebre era troppo faticoso.
Provò a passare la lingua sulle labbra screpolate, ma le sembrava di avere in bocca un pezzo di cartone. Asciutto.
Asciutta la pelle. Asciutto il suo seno, con cui sperava di poter nutrire Ibrahim, fino alla fine del viaggio. Asciutti gli occhi, nemmeno il sollievo di una lacrima. Asciutto lo stomaco, aveva vomitato tutto quello che poteva. Arrivò un altro conato a scuoterla, un odore improvviso di marcio, di piscio e forse di carne in putrefazione.
Non sapeva più da quanto tempo era per mare, se erano ore o giorni.
Aveva freddo, nonostante il sole battente. Strinse a sé Ibrahim, il respiro lievissimo e affannoso.
Pregava Allah di portarselo via per primo, di lasciarle almeno il conforto di accompagnare il figlio verso la morte, e non lasciarlo solo. Perché ormai lo sapeva che fuggire non era servito a niente.
Metà dei suoi compagni di viaggio erano morti; chi ancora resisteva, come lei, non aveva nemmeno più la forza di chiamare aiuto; erano in balia della corrente.
Gli aguzzini sulle coste da dove erano salpati, avevano costretto al comando qualcuno più disperato di lei, puntandogli un fucile in mezzo alle scapole.
Non c’era scelta: morire subito, per un proiettile, o dopo una lenta agonia, di fame, sete, freddo. Aggrappandosi alla speranza che il rottame su cui erano stati obbligati a salire non affondasse, e approdasse vicino alla terra ferma, soccorso da quei ragazzi giovani, vestiti di bianco come angeli, che vedeva sempre alla televisione.
Gli angeli del mare li aveva soprannominati lei, che però adesso non volevano apparire.
Nel dormiveglia si trovava a ripensare al suo mare, all’oceano caldo che le avvolgeva le caviglie in gorghi schiumosi quando andava incontro al marito, aiutandolo a svuotare la piroga dai pesci pescati nella notte, per rivenderli al mercato.
Ibrahim legato sulla schiena emetteva gridolini eccitati, un misto di gioia e paura, ogni volta che uno spruzzo lo colpiva sul faccino.
E lei si caricava sulla testa ceste pesanti stracolme di pesci, che avrebbe pulito con calma, scacciando le mosche, in attesa dei clienti.
Il mare che dava loro da vivere adesso li stava facendo morire.
E ancora non riusciva a crederci.
La notte era silenziosa, come solo le notti in mare.
La barca sembrava respirare, lievi scricchiolii come sospiri e le onde lente che ne accompagnavano il ritmo. Mino non riusciva a dormire. Erano in mare da due settimane ormai e ancora non si vedeva l’ombra di un pesce. Pensava ad Angela.
Se la immaginava dietro alla finestra, stringersi nelle braccia e scostare la tenda scrutando l’orizzonte in cerca della sua barca, e ringraziare quel mare amato e odiato per averle restituito ancora una volta il suo uomo.
Pensava alla sua pelle morbida sotto le mani ruvide, screpolate dal sale e dal freddo. Alla sua isola, che lo faceva sentire come un Ulisse lontano da Itaca.
A quel mare che lo accompagnava da tutta la vita, che circondava quello scoglio dove era nato, che si ostinavano a chiamare isola, e riempiva ogni spazio vuoto della sua anima contaminando persino l’acqua che beveva, che gli aveva tolto un padre quando era bambino e che gli aveva restituito dopo anni lo stesso mestiere per vivere.
Il sonno lo colse mentre sognava Angela con indosso il suo vestito preferito.
Era passata un’altra notte.
Il primo pensiero era che era ancora viva, nonostante avesse le gambe e le braccia intorpidite, non avrebbe saputo dire se a causa del freddo o della posizione costretta nel sonno.
Subito dopo si rese conto che qualcosa mancava, un vuoto improvviso, un freddo più profondo dell’umidità mattutina.
Era un respiro mancato, la condensa sul suo petto, il battito del suo cuore all’unisono con quello del figlio. Che giaceva ora inerme tra le sue braccia.
Provò a scuoterlo inutilmente, non sapendo se sperare o temere che dormisse profondamente. Ma Ibrahim non reagì. Il corpo ancora tiepido svelava che era morto da poco.
E allora maledì Allah, per averla strappata dalla sua terra, per essersi preso suo marito prima e suo figlio adesso. Singhiozzi secchi la scuotevano, non aveva più lacrime, più forze né speranza.
Implorava Allah che prendesse anche lei, adesso era pronta a passare attraverso questa prova, era sollevata al pensiero che il tormento della sete e del freddo per Ibrahim fosse terminato e non chiedeva nient’altro anche per se stessa: raggiungere suo marito e suo figlio nel paradiso dei martiri
Uscì in coperta indossando il solito giaccone pesante e il berretto di lana ruvida calato sulla testa.
Il freddo intenso gli entrava nelle ossa, e nemmeno il tè bollente riusciva a riscaldarlo.
Si godeva gli ultimi attimi di calma prima che le attività frenetiche sulla barca cominciassero, attendendo l’alba. Non comprese subito cosa fosse quella macchia sull’orizzonte che schiariva col sorgere del sole. Poi la vide.
“Gesù…”
L’esclamazione gli morì in gola, e mille immagini che altre mille volte aveva visto al telegiornale gli scorsero davanti: sguardi di morte, corpi gonfi che galleggiavano nell’acqua, volti arsi dal sole e dal freddo, coperte termiche di alluminio, bambini passati di mano in mano.
“Salvo! Mario! Correte, Cristo! Correte!!”
I ragazzi fecero capolino, gli occhi rossi dal sonno, i capelli scarmigliati.
“Mino che è? Che ti gridi?”
“Accendete i motori svelti, che laggiù c’è una barca di disperati che ha bisogno di noi.”
“Mino ma che minchia dici? – fece Salvo scrutando l’orizzonte – lo sai che finiamo in un mare di guai, ci sequestrano la barca! Finiamo dentro per traffico di clandestini, ci roviniamo!”
Mino lo guardo storto, incredulo
“Salvo ma sei serio? Quelli muoiono! Sono già morti! Accendi quei maledetti motori! Ora! E avvisa la Capitaneria, che appena rientriamo nelle acque nazionali devono correrci incontro.”
Mario e Salvatore si misero ai comandi, di malavoglia.
Mino era in fibrillazione, non sapeva cosa fare, non sapeva cosa avrebbero trovato, quanti vivi, quanti morti, e se c’erano dei malati? E i bambini? Non avevano niente a bordo, non avevano nemmeno abbastanza spazio, Dio cosa gli era andato a capitare.
Si avvicinavano troppo lentamente, ogni minuto era prezioso, era già troppo tardi.
La sagoma si faceva sempre più grande e definita.
“E hanno il coraggio di chiamarla barca quest’accozzaglia di lamiera? Buon dio…” disse Mino sottovoce.
“Mino ma ora cosa facciamo?”
“Non lo so Mario. Non lo so”.
Si era addormentata di nuovo, sperando di non svegliarsi più
Il tormento della sete era ormai così familiare da non fare nemmeno più male.
Sentiva un ronzio nella testa, e maledisse Allah che non la voleva con sé, che le faceva bere fino all’ultima goccia di quel calice amaro. Il ronzio non cessava, allora chiuse gli occhi e ripercorse quello che era successo e che l’aveva portata fino lì. Le passarono davanti agli occhi lo sguardo di suo marito che la imploravano di fuggire, i corpi riversi nel sangue dei suoi vicini di casa, le foresta, la pioggia, il deserto, i guerriglieri col volto coperto, i mitra spianati, gli occhi del diavolo che l’avevano stuprata chiedendole di essere docile per avere salva la vita, i giorni interminabili sulla costa in attesa di imbarcarsi verso quel viaggio senza speranza, la paura, la fame, la fatica, il terrore di ritrovarsi Ibrahim morto tra le braccia.
Provava ad immaginare la sua nuova vita; avrebbe vissuto, per Mohammed, perché il suo sacrificio non fosse vano. Se solo fosse riuscita a raggiungere sua cugina in Francia, avrebbe potuto trovare un lavoro, mandare Ibrahim a scuola. Anche lei sarebbe andata a scuola, per imparare la lingua nuova, dopo il lavoro. Si immaginava tornare a casa la sera con le borse della spesa, girare la chiave nella toppa, salutare sua cugina che stava già dando da mangiare a Ibrahim… ma cos’era quel ronzio incessante? Il ventilatore forse?
Si riscosse. Il ronzio era sempre più forte, più vicino. Erano arrivati. Ma era troppo tardi.
Lo spettacolo che gli si parò davanti era peggio dell’inferno.
Nemmeno Dante avrebbe saputo disegnare un girone più crudele e disumano.
I corpi erano dappertutto, uno sull’altro. Morti sui vivi, vivi sui morti.
Il pavimento della barca era coperto di ogni secrezione umana; il tanfo era insopportabile e Mario dovette voltarsi per vomitare come non gli capitava da anni, abituato com’era al mare ormai.
“Presto, dobbiamo portare via quelli vivi e chiamare la Capitaneria, presto, presto!”
Mino si aggirava tra i corpi, non aveva guanti o mascherine, non sapeva cosa fare, toccava i corpi cercando di capire chi ancora respirava e chi no.
Aiutò un ragazzo ad alzarsi e lo accompagnò fino a Salvatore. Mario era tornato sul peschereccio improvvisando una passerella per far scendere i superstiti al sicuro.
Mino sembrava un pazzo, urlava ordini, supplicava Dio di dargli la forza di salvare più persone possibili.
Aveva il terrore di dimenticare qualcuno, erano centinaia, visi neri come la melma sul fondo dell’imbarcazione, lo sconforto lo colse all’improvviso. Si gettò la testa fra le mani non sapendo più cosa fare.
“Mino non c’è più niente da fare, sono tutti morti, andiamo via prima che quelli che abbiamo sulla barca facciano la stessa fine” Lo aiutò ad alzarsi e si incamminarono verso il peschereccio.
Un gemito lo fece voltare. Dove? Dove?
Mino tornò sui suoi passi come una furia, e finalmente la vide.
Era riversa su un fianco, gli occhi lo specchio dell’orrore, aggrappata a un fagotto da cui non c’era verso di separarla.
“Vieni, ti aiuto io, vieni”
Lei lo guardava smarrito, a stento si reggeva in piedi.
Mino, sgomento, si rese conto che nel fagotto che stringeva al petto c’era un bambino, poteva avere al massimo due anni, morto.
“Tuo figlio? Your child?” le fece indicandola col dito
Lei annuì muta.
“Ok, vieni.”
La aiutò a scavalcare il parapetto traballante. Erano quasi al sicuro, sul suo peschereccio, quando accadde, Mino non avrebbe nemmeno saputo dire come.
Un attimo prima, lei era aggrappata a lui, come se fosse l’ultimo uomo sulla terra.
Poi lo guardò negli occhi, uno sguardo indecifrabile, che Mino riuscì ad interpretare con un secondo di ritardo, sufficiente perché lei, con le ultime forze rimaste, gli sussurrasse “I can’t leave him alone, I’m sorry…”
E mollò la presa proprio nel momento in cui erano sospesi tra le due imbarcazioni.
L’acqua gelata le entrò nella pelle come spilli, che le trafissero il corpo prima e i polmoni poi, tranciandole il respiro.
Poi arrivò, inaspettato, il calore. Nel ventre, nella testa, nelle gambe.
Finalmente il calore, e la luce della sua terra.
- Tagged: , Attualità, immigrazione, mare, Racconti
- POSTED IN Racconti
- fiducia
- musica
- vita da single
- vita
- 8 marzo
- Guerra
- Inverno
- winter
- Torino
- immigrazione
- Salone del libro
- burian
- frozen
- freddo
- Collaborazioni
- figli
- Pilates
- Bullismo
- Sport
- Benessere
- Ghost
- Film
- Alluvione
- Halloween
- Anni '90
- Moda
- Parigi
- Nonna
- Mostre
- discr
- violenza
- 25 Novembre
- andrà
- valigie
- gabbia
- camminare
- il corpo del
- G8
- incipit
- partenze
- tiger
- ridere
- decathlon
- dormire
- inizi
- fine
- mestruazioni
- love
- 11 settembre
- relaz
- rivoluzione
- politica
- social
- Gli invisibili
- aborto
- festa del papà
- black lives matter
- gabbiere
- felicità
- happinessa
- andràtuttobene
- Immuni
- Buenos Aires
- Migranti
- Letture
- maschere
- Serie TV
- Settembre
- Blog
- Ricordi
- amicizia
- Storie di Donne
- pregiudizi
- Pubblicità
- san Valentino
- Amsterdam
- Diritti
- paura
- ragazzi
- inaugurazione
- mare
- il corpo delle donne
- Ponte San Giorgio
- femminismo
- Ballate
- New York
- Anno Nuovo
- Libri
- Figli senza diritti
- Bellezza
- scrittura
- travelling
- lockdwon
- pride
- Morte
- Natale
- Famiglie arcobaleno
- DAD
- Gender
- Attualità
- Tempo
- Arte
- Racconti
- Ponte Morandi
- omofobia
- razzismo
- Vacanze
- monamour
- scuola
- covid
- Famiglia
- Genova
- Estate
- omosessualità
- lockdown
- Viaggi
- A come amiche
- Bambini
- Donne
- coronavirus
- quarantena
- D come donna
- Discriminazione
- Amore
- Maternità
- Lifestyle
- Relazioni